Il Fattore umano nell’era dell’AI
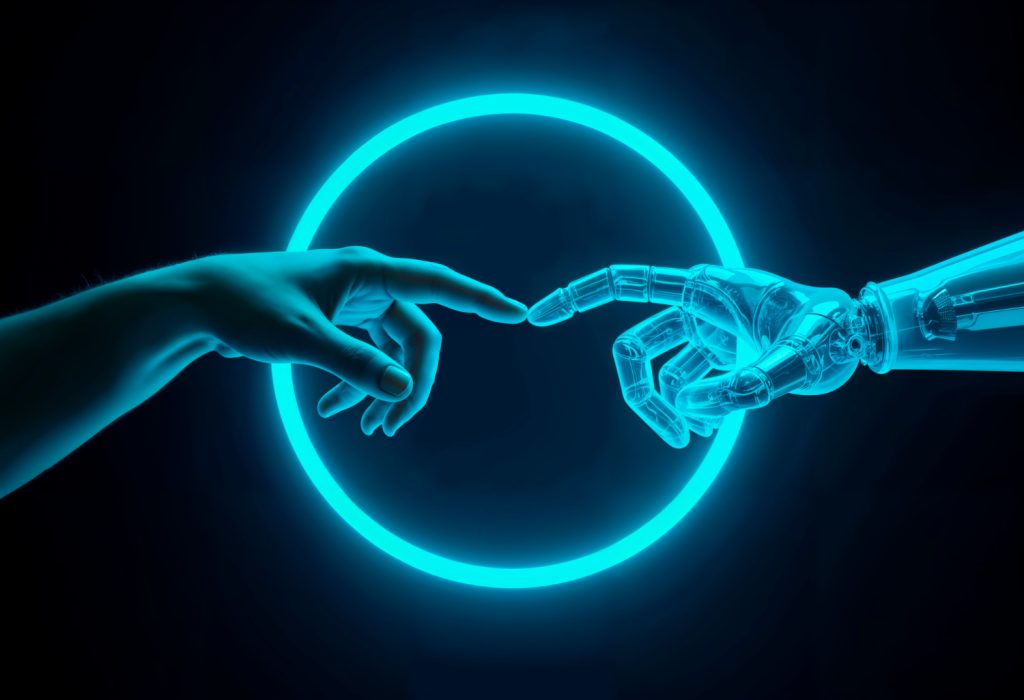
C’è un equivoco che attraversa questo tempo veloce: crediamo che basti “parlare” a una macchina perché accada qualcosa di utile.
In realtà, ogni volta che scriviamo un prompt non stiamo lanciando un incantesimo: stiamo progettando una decisione. Decidiamo cosa conta e cosa no, per chi stiamo lavorando, quale risultato vogliamo ottenere e con quali criteri giudicheremo se ciò che l’AI produrrà sarà davvero all’altezza.
Il prompting, se lo guardi da vicino, è decision design: la differenza tra chiedere un testo e costruire un esito.
Inizio sempre da qui, da un piccolo spostamento di sguardo. Il modello non è un oracolo, è un generatore di alternative. Fa comparire possibilità, ma non sa, da solo, quale sia la migliore per la situazione concreta che stai vivendo. Questa responsabilità rimane umana. Quando tratti l’AI come un copilota, il lavoro cambia: tu definisci il campo e le regole del gioco, lei esplora lo spazio delle mosse; più chiaro è il campo, più le mosse diventano utili.
C’è una frase che mi accompagna mentre scrivo, una specie di bussola mentale: “L’AI ci sta liberando la memoria, ma se le lasciamo anche il pensiero, cosa resta del nostro vantaggio umano?”
È successo già con Internet: abbiamo spostato fuori di noi una parte di memoria, abbiamo imparato a trovare più che a ricordare. All’inizio è stato liberatorio, poi, quasi senza accorgercene, abbiamo iniziato a confondere l’accesso con il possesso, il reperire con il comprendere.
Oggi il rischio è simile, solo più sottile: delegare all’AI non solo il lavoro sporco ma anche il giudizio, la scelta, la responsabilità di dire “questo sì” e “questo no”.
Umberto Eco, chiacchierando con Stefano Bartezzaghi, suggeriva che la cultura non è un magazzino di risposte ma una mappa per muoversi tra le domande. Non basta sapere dove cercare: bisogna saper valutare, integrare, usare. È questa la competenza che ci serve adesso: una metacompetenza, la capacità di governare il processo mentale più che di possedere il contenuto.
Se accetti questo cambio di paradigma, allora il prompting smette di essere una formula magica e diventa un’architettura: metti in fila il contesto, definisci l’obiettivo come azione attesa, stabilisci i criteri con cui giudicherai l’output, e solo dopo chiedi al modello di generare. Non gli domandi di pensare al posto tuo; gli chiedi di illuminare lo spazio delle possibilità perché tu possa scegliere meglio.
È qui che riaffiorano anche i rischi, molto umani, che l’AI non elimina, anzi potrebbe amplificare. C’è l’illusione di sapere, quella sensazione che affiora perché il testo suona bene, scorre, convince, finché non devi davvero difenderlo davanti a un cliente o tradurlo in una decisione che comporta costi e conseguenze. C’è la tentazione dell’automatismo, il pilota automatico con cui smetti di verificare le ipotesi, di cercare controesempi, di ascoltare l’ambiguità utile che complica all’inzio ma successivamente chiarisce; ci sono i bias, ancoraggi, conferme, scorciatoie, che non scompaiono: se non dichiari prima i criteri, il modello ottimizzerà ciò che trova, non ciò che serve.
Eppure, proprio in questo territorio che può sembrare fragile si nasconde l’opportunità.
Se ti abitui a progettare decisioni, l’AI diventa un analista paziente basta dirle chi c'è dall’altra parte, cosa speri che accada, quali vincoli vuoi rispettare. Le chiedi non una risposta, ma due o tre alternative plausibili e un breve ragionamento che spieghi perché ognuna potrebbe funzionare.
Tu non abdichi: valuti e nel valutare ti alleni e decidi.
Succede qualcosa di sottile: il tuo standard cresce, la tua attenzione si affila, il tuo tempo si compatta attorno a ciò che conta davvero.
Il modello ti restituisce velocità; tu gli restituisci direzione!
Tutto questo richiede disciplina cognitiva, che è la risorsa scarsa del nostro tempo. Mi piace pensarla come la somma di quattro ricchezze invisibili che alimentano ogni risultato visibile: tempo, energia, competenza, concentrazione. Se tratti il prompting come decision design, proteggi queste ricchezze:
- riduci le interazioni caotiche che ti mangiano il tempo;
- abbassi l’attrito che erode l’energia;
- crei standard che accumulano competenza;
- isoli finestre di lavoro profondo in cui la concentrazione non evapora.
Non è filosofia astratta: è igiene del pensiero in un’epoca che tende a moltiplicare le opzioni e a ridurre la nostra capacità di scegliere.
C’è poi un altro strato, più personale, che l’AI non tocca e che dobbiamo presidiare con cura. La tecnologia può generare testi impeccabili senza essere in grado di sostituire il gesto umano di attribuire significato. Dire “questo è giusto per noi, adesso” non è un calcolo: è un atto di responsabilità.
Vale in un’email importante come in una policy aziendale, nella risposta a un cliente come nella scelta di cosa non fare. Qui tornano utili le buone abitudini: una pausa di controllo quando l’emozione accelera, una domanda scomoda per testare le ipotesi, l’abitudine a chiedere una versione alternativa che sfidi la prima risposta. Piccoli rituali che rimettono il volante nelle nostre mani.
Alla fine, se guardi bene, il cosiddetto “fattore umano” non è un’etichetta romantica: è un insieme concreto di capacità che oggi diventano vantaggio competitivo.
- L’intelligenza emotiva che ti fa “sentire” l’altro e modulare il messaggio senza umiliarlo.
- L’intuizione informata dall’esperienza, che coglie il non detto e vede prima degli altri dove sta il rischio o l’opportunità.
- L’etica, che inserisce la dimensione delle conseguenze dentro ogni scelta e alza l’asticella del perché facciamo ciò che facciamo.
- La relazione autentica, che crea fiducia e rende possibile qualsiasi cambiamento.
Tutte qualità discretamente misurabili nella loro assenza, raramente celebrate nella loro presenza.
Per questo il punto non è “AI sì o no”, né “quanto la uso o quanto mi serve”.
La domanda che conta, dal mio punto di vista, è: come voglio pensare in un’epoca in cui posso delegare quasi tutto? Se l’AI ci libera la memoria, tanto meglio: avremo più spazio per il lavoro vero.
Il pensiero, quello che progetta, sceglie, assume rischi e responsabilità, resta nostro. E finché resterà nostro, il prompting non sarà mai magia: sarà il modo più onesto e potente per progettare decisioni che rispettano chi abbiamo davanti e che ci somigliano. In questo spazio, profondamente umano, sta ancora il nostro vantaggio!



